La casa (restaurata) di “Silvia”: una prospettiva inedita per il canto
libero di Giacomo Leopardi
(ap) Le finestre del
palazzo di famiglia affacciavano proprio su quella casa, adibita a scuderie, posta
in una piccola piazza di paese, nella quiete delle colline marchigiane, a pochi chilometri dalla Riviera del Conero e non lontano
dai Monti sibillini. Lì, nella
casa di fronte, a pochi passi, abitava Teresa Fattorini, la giovane figlia del
cocchiere, che vi trascorreva le giornate intenta a lavori di cucito e alla
tessitura di stoffe pregiate, e morì di tubercolosi a soli ventun anni.
Era lei la figura femminile,
alla quale si ispirò, anni dopo, Giacomo Leopardi quando scrisse A Silvia.
Dalla biblioteca disposta sull’angolo di casa, a Recanati, il poeta, “gli studi leggiadri talor
lasciando e le sudate carte”, la osservava “all’opre femminili intenta… e con
piacere… porgea gli orecchi al suon della tua voce, ed alla man veloce che
percorrea la faticosa tela”.
Nei lavori di restauro che
hanno interessato l’edificio per qualche tempo, il ritrovamento di residui di
tinteggiatura esterna ha riportato alla luce il tono di colore originario delle
scuderie, un bel rosso, vivo ma non sfacciato, mentre gli ambienti interni, rimessi
a nuovo e destinati ora all’ospitalità di viaggiatori interessati, sono stati
contrassegnati con i nomi di alcune componenti del telaio antico, Subbio, Spoletta, Navetta e Pettine, per ricreare un’eco di quell’epoca.
È insolita ed
inedita la prospettiva che è possibile sperimentare oggi, con la nuova vita di
quell’edificio restaurato accanto al palazzo che fu del conte Monaldo, il padre
del poeta. Non più guardare Silvia, immaginandone i pensieri, con gli occhi di Giacomo,
appena sollevati dalle carte e rivolti al di là delle finestre del suo studio.
Ma, attraverso lo sguardo di Silvia, luccicante di malinconia, osservare proprio
Giacomo, intento a scrivere nel palazzo di famiglia, ricurvo sulla scrivania, e
pervaso da un senso di insoddisfazione per la decadente vita di Recanati.
Del resto, l’immagine
di Silvia, un’adolescente con l’ “ignoranza completa del male” e “quell’aria
innocente negli occhi”, insomma “un fiore purissimo” (Zibaldone, 4310-11),
raggiunta dall’ombra della morte con troppa e ingiusta fretta, è in vero una
sorta di “specchio” dell’animo del poeta, la rappresentazione del suo stato
d’animo.
Nessun
concreto interesse sentimentale mosse a suo tempo il poeta verso quella
giovane, né gli sguardi rivolti dalla finestra turbarono mai il placido vivere
della fanciulla. Nessun ardimento amoroso. Non è perciò il moto dei sensi a
sollecitare la memoria di quel volto intravisto nelle stanze delle scuderie.
La sventura
di quell’esistenza così breve riemerge dolente a distanza di tempo quando il
poeta si trova a Pisa, una sede con uno strano “misto di cittadino e di
villereccio”, come scrisse in una lettera alla sorella Paolina. Il ricordo è
suggerito dall’osservazione della sua condizione presente, che per associazione
richiama alla mente l’antica visione giovanile.
Una
dimensione, quella della rimembranza, cruciale nella poetica di Leopardi come
cifra stilistica, e nello stesso vissuto dell’uomo. Il presente, oltre che poco
rassicurante per le occupazioni quotidiane, è anche meno poetico; la
divagazione poetica proietta inevitabilmente l’immaginazione “nel lontano, nell’indefinito,
nel vago” (Zibaldone, 14/12/1828).
Ebbene il
ricordo di quella fanciulla è destinato ad evocare la percezione di un limite
che nella vita è inevitabile attraversare, quello che segna il confine tra
giovinezza ed età adulta, tra aspettativa di vita e disillusione. La vicenda
biografica di Teresa rappresenta il disvelamento di un’illusione e con esso la
malinconia cocente vissuta al momento della maturità. E’ l’emblema del disincanto
percepito con il raggiungimento dell’età adulta e la perdita delle illusioni
coltivate nella fanciullezza.
Nella
corrispondenza immediata tra il destino della giovane tessitrice e la condizione
disillusa del poeta ormai entrato nella maturità è percepibile il drammatico
attraversamento di quella soglia esistenziale: non c’è più spazio per le
illusioni della fanciullezza. L’io poetico, traendo spunto dal ricordo della
precoce morte di quella dolce figura femminile, abbraccia così temi universali sulla
sorte delle “umane genti”, come l’infelicità dell’uomo e il crollo delle
speranze, intrecciate alla malinconia insita nell’età adulta.
L’intrinseca
caducità degli eventi impedisce di coltivare ancora delle illusioni. Tutto rende
così difficile respirare il desiderio di vivere ed amare, e di lottare contro
la morte percepita come implacabile e sempre incombente, rendendo inevitabile
un afflato di malinconia: l’io non può che essere profondamente compassionevole
verso se stesso come verso tutto il genere umano.
Una
condizione che, nel racconto poetico, induce a svincolarsi da ogni restrizione di
stile o schema poetico, creando un approdo lirico nuovo. Nei versi non c’è protesta ma elegia, non è
formulata alcuna accusa ma solo espresso un mesto compianto nella consapevolezza
dell’inevitabile dolore del vero di fronte ad una natura tanto ingrata.
Percezioni profonde
e complesse, appunto universali, che possono essere espresse solo in una forma
totalmente libera, depurata dai vincoli stilistici delle strofe e delle rime.
E’ davvero un canto libero quello che, adottando un linguaggio oltre i confini
conosciuti, racconta la giovanile attesa della bellezza della vita, la
percezione ingannevole della felicità, la crudezza del disincanto per la
perdita della “speranza mia dolce”, la sensazione delle sofferenze vissute
nell’età adulta “all’apparir del vero”.
A Silvia
di Giacomo Leopardi
Silvia, rimembri ancora
quel tempo della tua vita mortale,
quando beltà splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa, il limitare
di gioventù salivi?
Sonavan le quiete
stanze, e le vie d'intorno,
al tuo perpetuo canto,
allor che all'opre femminili intenta
sedevi, assai contenta
di quel vago avvenir che in mente avevi.
Era il maggio odoroso: e tu solevi
così menare il giorno.
Io gli studi leggiadri
talor lasciando e le sudate carte,
ove il tempo mio primo
e di me si spendea la miglior parte,
d’in su i veroni del paterno ostello
porgea gli orecchi al suon della tua voce,
ed alla man veloce
che percorrea la faticosa tela.
Mirava il ciel sereno,
le vie dorate e gli orti,
e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
Lingua mortal non dice
quel ch’io sentiva in seno.
Che pensieri soavi,
che speranze, che cori, o Silvia mia!
Quale allor ci apparia
la vita umana e il fato!
Quando sovviemmi di cotanta speme,
un affetto mi preme
acerbo e sconsolato,
e tornami a doler di mia sventura.
O natura, o natura,
perché non rendi poi
quel che prometti allor? perché di tanto
inganni i figli tuoi?
Tu pria che l’erbe inaridisse il verno,
da chiuso morbo combattuta e vinta,
perivi, o tenerella. E non vedevi
il fior degli anni tuoi;
non ti molceva il core
la dolce lode or delle negre chiome,
or degli sguardi innamorati e schivi;
né teco le compagne ai dì festivi
ragionavan d’amore.
Anche perìa fra poco
la speranza mia dolce: agli anni miei
anche negaro i fati
la giovinezza. Ahi come,
come passata sei,
cara compagna dell’età mia nova,
mia lacrimata speme!
Questo è il mondo? questi
i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi,
onde cotanto ragionammo insieme?
questa la sorte delle umane genti?
All’apparir del vero
tu, misera, cadesti: e con la mano
la fredda morte ed una tomba ignuda
mostravi di lontano.
quel tempo della tua vita mortale,
quando beltà splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa, il limitare
di gioventù salivi?
Sonavan le quiete
stanze, e le vie d'intorno,
al tuo perpetuo canto,
allor che all'opre femminili intenta
sedevi, assai contenta
di quel vago avvenir che in mente avevi.
Era il maggio odoroso: e tu solevi
così menare il giorno.
Io gli studi leggiadri
talor lasciando e le sudate carte,
ove il tempo mio primo
e di me si spendea la miglior parte,
d’in su i veroni del paterno ostello
porgea gli orecchi al suon della tua voce,
ed alla man veloce
che percorrea la faticosa tela.
Mirava il ciel sereno,
le vie dorate e gli orti,
e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
Lingua mortal non dice
quel ch’io sentiva in seno.
Che pensieri soavi,
che speranze, che cori, o Silvia mia!
Quale allor ci apparia
la vita umana e il fato!
Quando sovviemmi di cotanta speme,
un affetto mi preme
acerbo e sconsolato,
e tornami a doler di mia sventura.
O natura, o natura,
perché non rendi poi
quel che prometti allor? perché di tanto
inganni i figli tuoi?
Tu pria che l’erbe inaridisse il verno,
da chiuso morbo combattuta e vinta,
perivi, o tenerella. E non vedevi
il fior degli anni tuoi;
non ti molceva il core
la dolce lode or delle negre chiome,
or degli sguardi innamorati e schivi;
né teco le compagne ai dì festivi
ragionavan d’amore.
Anche perìa fra poco
la speranza mia dolce: agli anni miei
anche negaro i fati
la giovinezza. Ahi come,
come passata sei,
cara compagna dell’età mia nova,
mia lacrimata speme!
Questo è il mondo? questi
i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi,
onde cotanto ragionammo insieme?
questa la sorte delle umane genti?
All’apparir del vero
tu, misera, cadesti: e con la mano
la fredda morte ed una tomba ignuda
mostravi di lontano.

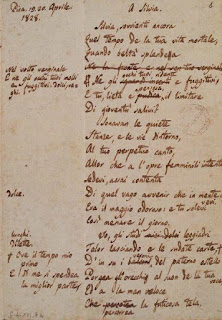
Nessun commento:
Posta un commento